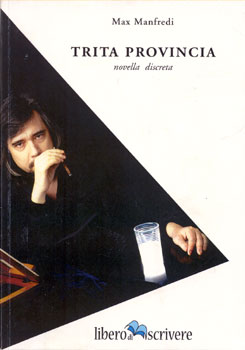Intervista a Max Manfredi, uno tra gli artisti più originali e interessanti nel panorama della canzone d’autore italiana (e non solo).

Genova, che compare spesso nei tuoi testi in un senso esplicito o meno: “Storie del porto di Atene” è sempre lei, la tua città, quanto ha influito sul fare di te, quello che sei?
Dico spesso che Genova è un set, dove “filmo” le riprese che compongono le mie canzoni. Anche nelle “storie del porto di Atene” si parla da un ambiente che può essere benissimo quello genovese. In realtà però questa canzone mi è venuta in mente nella stazione di Asti. E’ il bello dell’allegoria, parlare d’altro senza che ci sia bisogno di capirlo. Vedi, Gisela, quando uno sogna, sogna anche frammenti di realtà vissuta: vista, toccata, odorata o adorata. Il clima della mia città, con tutti i suoi difetti, è variegato e forte, sarebbe strano che non lasciasse impronte su ciò che scrivo e vivo.
Il tuo primo esordio ufficiale è stato nel 1990 con l’album “Le parole del gatto”, e già in questo si notano suoni e contaminazioni di derive musicali differenti che s’intrecciano tra un brano e l’altro, caratteristica che porti in tutti i successivi album…Come si arriva a quel primo album, e come si riesce a mantenere un proprio stile con tanta variabilità?
Riascoltando “Le parole del gatto”, anni fa, mi sono reso conto di quanto radicale, estremo, pure desolato, fosse il mio “tagliarmi fuori” dal tempo in cui ho inciso questo cd. Sembra una polemica fatta apposta, ma è soltanto uno sfogo lirico dove la sincerità non corrode la maschera necessaria più di tanto. Mi ricordo che, pochi anni prima, mi presentai alla rassegna Tenco (per la seconda volta) dicendo: “Sono felice di essere qui, alla rassegna Tenco, dove si possono fare brani ironici, scanzonati, divertenti… ed anche autentiche menate, come queste che vi faccio ascoltare”. C’era di moda uno sgarzulinismo un po’ furbetto, un po’ da deficienti… i giornalisti ci cascavano come pere. Il mio cd è uno dei pochissimi documenti antagonisti dell’epoca… non ne sono fiero, ma è così. Controllate per credere. Quanto allo stile, è un fatto, spero felice, di schizofrenia più o meno controllata. A quel primo album si arriva con un pugno di canzoni “nuove”, mentre le più antiche le ho riprese dopo, e secondo una facile ironia delle cose d’arte, sono, in un certo senso, più “nuove”…
Nell’album “Max” (1994) compare il brano “La fiera della Maddalena” che è in uno splendido duetto con Fabrizio De Andrè. Come nasce l’idea di un brano assieme, l’idea di quel brano in particolare, e la sua realizzazione tecnica ? Non credi che sia comunque stranamente poco conosciuto rispetto tutti gli altri brani dello stesso autore, cioè voglio dire, di solito non scappa nulla su Fabrizio…?
Ho anche proposto alla BMG di ristamparlo con un minimo di “packaging”, ma la cosa non ha avuto esito. Anzi, credo che il cd sia tuttora fuori catalogo. In realtà alla BMG mi hanno garantito che l’avrebbero rimesso in catalogo. Sorvolo su ogni possibile commento riguardo all’inadeguatezza troppo spesso proverbiale delle major, travestita da corretta coscienza finanziaria. In breve è stato così: Vanni Pierini (premio Città di Recanati), invitato in Sardegna da Fabrizio, gli ha portato una mia cassetta. Lui ne è rimasto impressionato (me ne sono stati riportati due commenti, che qui cito con beneficio d’inventario: “Questo è uno stronzo, perché non fa nulla per avvicinarsi al pubblico…”“Questo qui è più avanti di me e Ivano messi insieme”). Così l’ho conosciuto di persona (prima non lo conoscevo) e abbiamo deciso di incidere insieme uno dei pezzi. Abbiamo scelto “La fiera della Maddalena” che, originariamente, durava dieci minuti. L’ho accorciata, su accorata raccomandazione del mio produttore di allora… intanto non racconta una storia, quindi si poteva fare.
Molti ti conoscono proprio per il fatto di aver collaborato con “il poeta genovese”, e questo sicuramente è un valore aggiunto, ma secondo te può essere anche un limite al fatto di essere in tutto e per tutto Max, cioè quanto te ti sentiresti te adesso senza quella collaborazione, e quanto ti senti riconosciuto per lo stesso motivo?
Non me ne frega niente. Se uno è così ottuso da non riconoscere il valore di un artista indipendentemente da pubblicità o raccomandazioni, o da “mi manda Picone”, non è un buon ascoltatore. E’ un pesce da pubblicità. Vuol dire che se qualche produttore deciderà di spendere qualche migliaio di euro per farmi propaganda (cosa, a onor del vero, mai avvenuta) quello abboccherà. Prima non avrebbe senso dimostrargli nulla, un po’ come la strega Nocciola nei fumetti di Pippo, hai presente? Oh, la santa e democratica aristocrazia delle cose d’arte!
Tu giochi tantissimo con le parole, doppi, tripli sensi, un’abilità e un equilibrio incredibile tra senso-dissenso, ironia, nostalgia, sacro-profano, metriche, assonanze e significato sempre in sintonia… è appunto un gioco che nasce spontaneamente, con una certa semplicità o c’è dietro una ricerca ben definita, una costruzione artistica con mire ben precise?
Nasce dalla mia indole linguistica (e lirica), ma subisce un lungo lavoro di affinamento. L’indole lirica, secondo me, è una sorta di percezione spostata delle cose: che, immediatamente, ti si presentano in immagine e metafora. Può essere allenata, ma è anche innata. Quindi, il gioco è molto semplice, ma la scelta è severa. Quanto al senso e al dissenso, e al risicato equilibrio fra sacro e profano, questo è il mio marchio, la mia cifra poetica. Nella canzone (è per questo che l’amo) c’è abbandono ed artigianato, azzardo e consapevolezza. E’ comunicazione, ma comunicazione magica, sfinge, sorpresa, incantamento, ipnosi.
Mi pare di sentire che dietro a questa magnifica complessità artistica, c’è una gran spinta della sofferenza, una sofferenza con radici crepuscolari, francesi talvolta anche un po’ blues, o mi sbaglio?
Ma io ti sposo. E’ tutto vero, in una precedente intervista mi fu fatto notare (da Ivano Malcotti, Moleskine, c’è sul mio sito) che il mio è un crepuscolarismo urlato, graffiante. Ora urlo molto meno, quantomeno sui dischi; ma gli ho risposto che i lupi, al crepuscolo, ululano, non bisbigliano mica. Sono i preti che bisbigliano. Nelle mie nuove canzoni c’è un urlo implicito, sussurrato (che a volte però si scatena). Francesi le radici nel senso di Brel (belga, in realtà… era lui che diceva che, nel fragore del mare fiammingo, non potevi sussurrare “ti amo” ad una ragazza, dovevi gridarlo) ma ancor di più se si parla di Baudelaire. Che, quanto a gioco (doloroso) fra sacro e profano, aveva solo da insegnarmi. E non solo in questo, Baudelaire è uno degli ultimi maestri che (mi) riconosco. Ma tu parli del blues, e io, senza essere un esperto, mi rivedo in questo dolore popolare. Puoi chiamarlo anche rebetiko, in Grecia, o trovarlo nel fado. Popolare ed aristocratico, come la gente che si azzuffa nei bar. “Cantaci qualcosa che sappiamo tutti”, “Facci qualcosa di allegro”: sono le richieste che l’incauto chitarrista e cantante può sentirsi fare nelle festicciole dove non conosce nessuno. Sono due esigenze comprensibili, ma gregarie, che non rendono giustizia alla purezza del cantare, alle sue possibilità. Cantare è un dono, un dono, che costa fatica coltivare, e quindi è anche giusto che sia retribuito. Sorvoliamo sul fatto che, nelle stesse evenienze, non chiedo ad un dentista di darmi un’occhiata ai molari, o ad una commercialista di calcolarmi l’Irpef.
Sempre nei tuoi testi compaiono tantissimi riferimenti letterali, e figure, simboli legati al sacro. Come nascono queste passioni letterarie, poetiche, religiose sulle quali ti soffermi, e quali sono state le opere dal quale ti sei sentito maggiormente influenzato?
In parte ti ho già risposto. La canzone è piena di riferimenti sacri, fin dalle sue origini. Anzi, originariamente era lei stessa, un fatto sacro. “Sacro” significa insieme reietto e recintato. “Profano” significa “sulla porta del tempio”. Io sono un profano, un cane in chiesa. Oppure uno misteriosamente accettato da un giro di iniziati che neppure conosce. Fai tu. Sono stato influenzato dal virus di alcuni poeti. Voglio almeno citare Enrico Heine e Guido Gozzano. Le splendide scosse campaniane mi hanno colpito, ma non con un vero shock of recognition, come nel caso di questi altri due grandi. Per la musica, il mio orecchio barbaro ha saccheggiato un po’ di qua e un po’ di là. Ma perché andare a scopiazzare De Gregori quando c’è Schubert a portata di mano?
Può essere che la “conoscenza” e la “cultura” influenzi le emozioni, “il cuore”?
Il cuore e l’emozioni sono più importanti e più forti della cultura. Ma la cultura non puoi sostituirla, se non con la sottocultura: ormai non c’è più spazio per una stupenda ignoranza, per la “grande ignoranza” invocata dagli antichi gnostici: false informazioni ne fanno un aborto di furbizia ed arroganza. Quindi bisogna cominciare ad avere rispetto della cultura: quella dei vini, dei formaggi, ma anche quella della canzone, dei fumetti o dei film. Solo così potrà accompagnare le emozioni ed il cuore, e le loro sante esigenze e contraddizioni, il loro battito ed il loro respiro.
Te sei stato ospite varie volte del premio Tenco, quanto secondo te queste manifestazioni hanno a che fare con il nome che le sostengono? Che ricordo hai riguardo?
Un ricordo bello, legato alla figura di Amilcare Rambaldi, e ad altri che ho conosciuto lì (ad esempio Dave Van Ronk, il folksinger che fu, in un certo senso, “maestro” di Bob Dylan). Una atmosfera simpatica, un poco goliardica (ecco, per le anime più sensibili il maggior difetto è un sospetto di sfiorato “nonnismo”). Che poi servano, manifestazioni come questa, è altro discorso. Ma si può applicare il beneficio del dubbio (e il dubbio del beneficio) anche al festival di Sanremo. Quanto c’entri Tenco, non so, come non so quanto c’entra Ciampi con l’omonimo premio livornese. E fra migliaia di anni, quando faranno un premio a mio nome – spero che ciò non avvenga, o avvenga il più tardi possibile – non c’entrerà nulla con me. Ma il “Tenco” è nato con un nobile intento: cercare di fare in modo che i migliori artisti abbiano una specie di ecosistema per non perdersi (anche se, ad una visione più profonda, l’ecosistema dell’artista è la sua stessa rovina). Che poi siano riusciti e riescano nell’intento, questo ovviamente è tutto da discutere. A volte mi viene in mente il paradosso: un grande artista misconosciuto non viene accettato alla rassegna Tenco, e si spara. Istituirgli un altro premio, che ripari all’ingiustizia ormai ricorsiva? O via dal karma, e alla svelta?
Qual è il brano a cui sei più affezionato, e quello che più ti piace?
Non so, tanti (ma non tantissimi). Miei e non miei. Tutti quelli che mi danno una scossa emotiva. Nina, di Gualtiero Bertelli. Monte Canino. Rondinella d’Aspromonte. Lilì Marlene. Sei minuti all’alba., di Jannacci e Fo. Ma tantissime altre… Le canzoni che non emozionano, secondo me, son da buttar via. Ma qui parlo dalla mia deformazione professionale, che è innanzi tutto una deformazione di gusto, il cortocircuito di una fiera rionale di neuroni che si accendono come lampadine, barbaramente. Queste canzoni mi piace cantarle, a fil di voce, anche nelle larghe notti genovesi, quando si fanno le ore larghe, quando c’è poca gente, quando ci sono intorno occhi che sanno ascoltare.
Quello che molti non sanno di te, è che sei anche autore di libri, quali “Il libro di Limerik. Filastrocche, poesie e nonsense (Vallardi, 1994) in collaborazione con Manuel Trucco e in ultima uscita “Trita provincia” , che tu definisci un libro NON con “plot”, ma con “una trama”, dici che NON è un libro democratico… ci dài qualche anticipazione riguardo?
Dico che non è democratico come non è democratico il centerbe, che fa settantadue gradi, e quindi ti stende, se non sei abituato (in realtà ti stende anche se sei abituato, ma con una diversa connivenza). Aborro, detesto la falsa democraticità degli spot pubblicitari. Rispetto il lettore in un modo molto semplice: non lo prendo per il culo o, se lo faccio, lo avverto continuamente! Magari è una forma di sadismo ingenuo. Ma glielo devo. Il plot non c’è, nel senso che non c’è interazione fra personaggi: sono scorci, filmini, descrizioni di scenografie, immagini. La trama sì, è la trama stessa della scrittura, come pratica arcana e familiare. Amo chi si riconosce in questo libro, è come avere un comune una tessera scaduta di un cineforum segreto cui si teneva tanto.
Una domanda del tutto personale: “Cosa ne pensi riguardo Piero Ciampi?
Lo ascoltavo da ragazzino. E’ assolutamente originale, fino all’arbitrio. Mi fa venire in mente certi ubriaconi antagonisti, agonisti, intelligenti e un po’ rompicoglioni che ho imparato a conoscere nei bar. Non so se sarei andato d’accordo con Ciampi. Ma forse sì. L’amico Pino Pavone ha un ricordo vivissimo di lui, pieno d’affetto, e conserva in casa le bottiglie da cui Piero ha bevuto: col risultato che adesso l’alcol è svanito, e non si possono più bere! Sì, forse sarei andato d’accordo: anche se son del tutto alieno dal gioco enigmistico, dalla prova di forza, dalla scommessa e dalla sfida da bar, dalle carte e dagli scacchi. Molti, non moltissimi, hanno un vero culto di Piero Ciampi. Io apprezzo la sua stralunata coerenza, anche quella di scrittore. Gli invidio un po’ una Roma viva, viziata, pigra e intellettuale (che gli stava alquanto sul cazzo) in cui il più stronzo che incontravi era Moravia, o Elsa Morante, o Fellini. Oggi ci incontri Bonolis, se proprio ti va di culo!
W.S. Burroughs scriveva “Quanto ci mette un uomo a imparare che non deve, non può volere ciò che “vuole”?. Io sono d’accordo ed è un’ammissione alla rassegnazione; secondo te c’è invece una via d’uscita a questa affermazione?
E’ una frase bella. Volere è un alibi, un altrove. Vogliamo sempre altrove. Ma a volte non voliamo altrove. Non c’è rassegnazione, c’è un fuoco furente in questa ammissione. Né volere, né essere voluti. Lontano, non facciamoci trovare. Altrove. Che poi è qui, fra le nostre mani. A Bali, o sotto casa.
Al giorno d’oggi c’è qualcosa che salvi musicalmente e culturalmente parlando? Cosa eleggi e cosa condanni in maniera plateale?
Cara Gisela, di questi tempi non c’è gusto ad essere plateali, e purtroppo nemmeno “osceni” (cioè fuori scena). Nemmeno c’è molto sugo ad essere elettori.Né posso salvare o condannare alcunché. Se però mi dici quello che amo, che voglio con me, che mi piace; sì, c’è qualcosa. Ora questo, ora quello.Quel che non amo è la musica gregaria, zumpa zumpa o tunza tunza che sia. Quella che fa battere le mani a tempo (oh, no, mai a tempo), fa pogare e bere birre, confondendo i fusti della spina coi serbatoi dei voti. Ciò che non amo in questa musica è che, col semplice fatto di esistere, nega l’esistenza di una musica migliore. La fa da padrone, ed è sbagliato. Ma parlo per me…Condanno senza appello e senza appalto l’uso del termine “cantautorato”. Chi usa questa parola è del tutto privo di sensibilità, non solo linguistica. La sua intelligenza, tutta voltata all’adattabilità, è tremendamente limitata ed ottusa. Non gli permetto, nella mia munificenza, di avere dei gusti. Prima, la rieducazione.
I tempi cambiano davvero, o si spostano solo le polemiche?
Bella questa! No, i tempi si attorcono su se stessi, come ben sanno le mitologie d’ogni clima. Le polemiche sono stormi scagazzanti. Non c’è alcun gusto a tessere polemiche. Con chi dovremmo polemizzare? E si spostano, ‘sti stormi. Come i ragazzini, finti e veri, quanto vanno di moda nuovi locali. Oppure le tristi migrazioni ai centri commerciali, dove la tristezza è un imperativo etico, come la coda o il risparmio! Questa non è polemica, è una desolata consapevolezza che, un po’ diabolicamente – un diavolo povero, da cicche – mi arrogo. Quasi in incognito.
Tre cose a cui non rinunceresti mai, e tre cose che potendo scegliere faresti sparire dal mondo…
Non so, non so cosa dirti. Le cose a cui se posso non rinuncio son ben più di tre, e le cose e le persone che dovrebbero sparire ancora di più… Per una questione ovvia, di pudore, vorrei sparisse l’auditel. E che la televisione diventasse un’altra cosa. E vorrei che non ci fossero le banche. E che ci si scambiasse valuta di baci.
Dove si è fermata la vera poesia, se dopo Gozzano si può ancora parlare in qualche modo di poesia..?
Si può. Ma con estrema umiltà, e con la consapevolezza che poesia ed editoria non hanno più nulla a che fare… se mai l’hanno avuto. Gozzano prendeva in giro, con pietà enorme, il commesso farmacista. Senza prova d’appello, decide che i suoi versi sono nefandità da melodramma (magari invece era molto più bravo di lui, ma i poeti sono spesso irriconoscenti). Ma proprio questa bassezza poetica testimonia, nel dolore, quella verità cui, secondo Gozzano, i poeti suoi contemporanei non potevano più attingere. Divorzio assoluto, o quasi, fra la bellezza (prostituzione) e la verità (incompetenza). Pensiero abissale e provinciale, quindi rispettabile. A Gozzano il merito di aver segnalato le colonne d’Ercole della poesia, la Gibraltar, acciocché l’uom più oltre non si metta (ma ci si mette, ci si mette). Montale, Caproni, Ungaretti, non l’hanno ascoltato, in realtà. Dobbiamo biasimarli? No, naturalmente. Ma forse avrebbero fatto bene.
Oggi dovremmo parlare di inquinamento poetico, come si parla di inquinamento acustico o ambientale. E’ verità banale che il numero di chi scrive versi supera di gran lunga quello di chi li legge. E ad una poesia, non si può perdonare nulla, mentre ad una canzone, organismo più complesso, sì. Una buona canzone può essere anche dei Pooh, mentre un poeta mediocre ed onesto è un controsenso. Questo inquinamento, questa inflazione poetica convive curiosamente con due “memi”, due tracce mnemoniche ormai insensate: la grandezza del poeta e la sua sanzione editoriale. Si continua a pensare che “poeta” sia un complimento, nonostante l’editto gozzaniano, il marchio ironico di vergogna: “io mi vergogno d’essere un poeta”.Se posso fare un appunto personale, divido i poeti contemporanei che mi capita di sogguardare in illeggibili e dignitosi. Ma Emily Dickinson, la piccola cara Emily, adolescente, diceva, in modo molto saggio: “poesia è per me quello che scoperchia il cranio e mette i nervi a nudo”.Quando leggo (ad alta voce, un altro dono che ho senza aver fatto scuole di recitazione) certe poesie di Pascoli – ovviamente non tutte – Leopardi o Dante, mi commuovo e mi entusiasmo fino alle lacrime, specie se ho corroborato l’emozione con qualche bicchiere di troppo, o se il pubblico privato che mi ascolta lo amo.Sono un barbaro, la poesia non mi interessa se non mi dà emozioni. Mi piace anche ricordare l’aforisma di Tom Waits: “Quando un mio amico mi dice ‘ti leggo una poesia’, immediatamente mi vengono in mente nove cose più divertenti da fare”. Ma anche Gozzano, che – oltre a vergognarsene - paragona la poesia ad un getto di morfina per i nervi inquieti. In realtà la poesia non è solo risultato di una pratica, ma è prima di tutto fame.
E' logico che i poeti dopo Gozzano (e Campana) non potevano, e non dovevano, appendere la lira al chiodo e snobbare le sudate carte, anche indipendentemente dagli esiti : non si può mica dire a uno di non mangiare, che altri hanno già mangiato piatti migliori di te. O convincerli che non è rimasto nulla. La fame è fame.
Il poeta è in effetti un protagonista nevrotico. Un bulimico, un anoressico, un sonnambulo: bisogna lasciarlo fare. Lo è indipendentemente dal suo valore. Non bisognerebbe nemmeno parlare di valore dei poeti, solo di gradiente poetico nelle poesie.
L'inquinamento poetico esiste, ma è un diritto. Tanto peggio per chi ha orecchie fini. Non solo, ma la poesia diventa spesso un mezzo per esorcizzare il dolore, o quantomeno risvegliare gli analgesici del narcisismo e/o del masochismo. Come puoi togliere questo diritto a chiunque?
Il problema è che l'esercizio della poesia tende a diventare, automaticamente, esercizio critico! Uno ha il diritto ad essere poeta, ma non a giudicare la poesia altrui. Su che basi lo farebbe? Invece ciò avviene naturalmente. E trasferisce indebitamente - forse indebitamente - la pratica poetica dall'ingiudicabile regno dell'eros a quello banale delle performance, sia pure divine. Le performance si possono giudicare, l'eros, no.
Qui i parassiti, più che i poeti, sono proprio i critici. Sono loro, e gli editori, che decidono l'indecidibile: cioè, per dirla brutta, chi sì e chi no, chi c'è e chi non c'è. Anche quando fingono di guardarsi intorno e decantare...
Si torna quindi alla perfetta diagnosi gozzaniana. Il vero poeta E' il commesso farmacista... IN QUANTO NON LEGGE I SUOI VERSI, figuriamoci pubblicarli. Gli altri, che li pubblicano, sono falsi poeti. Lui solo è immune dall'inferno del giudizio altrui , della critica (cioè del pettegolezzo).
"Non glieli leggo... che, una volta letti quei versi perderebbero ogni pregio...
Poi sarebbe un'offesa, un sacrilegio per la morta cui furono diretti". (cito a braccio)
Il poeta professionista, categoria di cui Gozzano rivendica ironicamente di far parte, è il "cortigiano" anzi, proprio "la" cortigiana "Vale ben più di noi, che, fatti scaltri, saputi all'arte come cortigiane (...) tentiamo il sogno per piacere agli altri." E' lui "donna pubblica", è lui che pubblica.
Ora la domanda è: esiste anche una catarsi della pubblicazione? E se sì, in cosa consiste? Nella comunicazione? Di che? Dei fatti propri o della perfezione formale? Non so. Io mi trovo ad affrontare sul palco il problema della performance, della lirica cantata. C'è sincerità ma anche molto gioco, molto sentimentalismo che - come diceva argutamente De André - si nega all'arte "alta", ma volentieri si concede a quella popolare, come è o dovrebbe essere, almeno nelle intenzioni, la canzone. E io, sul palco, son giullare ed insieme trovatore.
Ma la poesia è ancora "arte alta"? Quale poesia, poi? E, siamo alle solite, chi la giudica, chi la diffama, chi la giustifica? Chi si fida? Chi diffida? Chi parla?
Oggi davvero l’informazione è una forma di banalizzazione del sapere?
E’ banalizzazione del non sapere! E’ infelice ignoranza. E’ dittatura sputtanata da democrazia. Anche qui parlerei di inquinamento dell’informazione (Baudelaire diceva che non concepisce come si possa leggere un giornale senza dopo lavarsi le mani). D’altra parte, è meglio sapere le cose che succedono piuttosto che ignorarle, o almeno, questo sembra rassicurarci, cioè causarci angoscia. Finché proviamo angoscia siamo vivi, e grati ai farmaci.
Se in nome di Dio ci hanno insegnato a rispondere “Amen”, in nome di Max cosa si dovrebbe rispondere?
Strana domanda. Si dovrebbe aprire le labbra, con un sorriso, e chiuderle con un bacio. Come la rivoluzione. Ma non per merito, solo per gentilezza. Perché altre monete non abbiamo.
Scrivi e componi anche testi per altri artisti?
Sì, se capita. Ad esempio ho collaborato con Andre Ceccon e le Voci Atroci. Non mi dispiacerebbe dare qualche mia canzone a qualche brava cantante famosa.
Quando finisci o crei un album, o un brano, a chi pensi come potenziale ascoltatore?
Ingoiando me stesso, dandomi per implicito e svanendo come ascoltatore,penso a quei tre o quattro che sentono le mie canzoni in "quasi privato", nelle case o nei locali scivolati ben oltre l'ora di chiusura, quando l'incantesimo serra le porte e riaccende, in barba a Sirchia, le sigarette, e persino (questo in barba a tutto il mondo, invece) lacrime clandestine negli occhi di chi ascolta. Ecco, voglio che un cd sia prezioso, cioè non debba esserlo, ma possa esserlo per qualcuno. Che sia vivo. Penso che se gli amici e gli avventori casuali sono conquistati dalla magia, possono esserlo anche centinaia, migliaia di persone. A volte pesco brani di trent'anni fa, che il tempo ha come ripulito, e che non avevano altra pretesa che parlare in musica di emozioni, e quindi ne parlano tuttora. In casi come questi, in atmosfere così, si capisce quanto idiota sia l'attualismo, quanto bisogna essere poveri di spirito e straricchi di cazzate per pensare in categorie come "vecchio" e "nuovo", come fanno i cronisti peggiori. Finché ci sono "occhi che ascoltano" so che va bene che io suoni e canti. E' un incantesimo trasversale. Quando va bene. E deve andare bene sempre.
Collaborazioni e prossime realizzazioni…
Spero di collaborare presto con qualche produttore migliore da quelli avuti finora… quanto ai musicisti, vanno benissimo, grazie. E’ il problema che proprio non ho…
Una frase o un appello che vorresti dire a tutti…
No, perché ogni appello è un “vota antonio la trippa”. Questo è il grave limite della politica, e dello sport: il suo senso gregario (o da branco, che non è più nobile). Quindi, il mio appello è : “non ascoltate questo appello”. Dopo tutto sarà più facile.
Sito ufficiale: www.maxmanfredi.com
Album pubblicati

Live in Blu (2004)
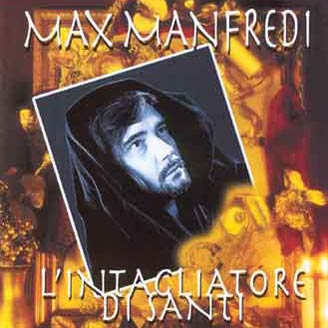
L'Intagliatore di Santi (2001)

Max (1994)

Le parole del gatto (1990)
Foto di Patrizia Biaghetti ed Augusto Forin
Scritti e Libri
Il Limerick è una strofetta buffa e insensata di cinque versi rimati AABBA di ritmo giabico-anapestico, che generalmente contiene nel primo verso il riferimento ad un luogo geografico. Max ha scritto insieme a Manuel Trucco "Il libro dei Limerick. Filastrocche, poesie e nonsense" (Vallardi, Milano 1994). Il libro include una prefazione di Stefano Bartezzaghi, oltre trecento limerick originali e una dotta e dettagliata storia del limerick scritta da Pier Paolo Rinaldi.
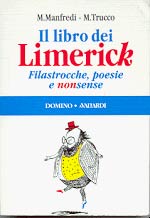
«Trita Provincia» è un libro che ho scritto. E' inedito. Non è il tipico "dattiloscritto nel cassetto"; lo tengo nella libreria, insieme agli altri classici. Dal momento che è semisconosciuto, posso parlarne senza modestia: è la dimostrazione palese che un cantautore può anche saper scrivere. E' un libro di "romance", non un romanzo. Ha una trama, non un "plot". Non è molto democratico, così come non lo è un liquore ad altissima gradazione. Scritto da chi sa scrivere e per chi sa leggere. Per ordinare TRITA PROVINCIA scrivere a acassan@liberodiscrivere.it